Scritti
della bibliografia generale, scritti di Vietri e su Vietri
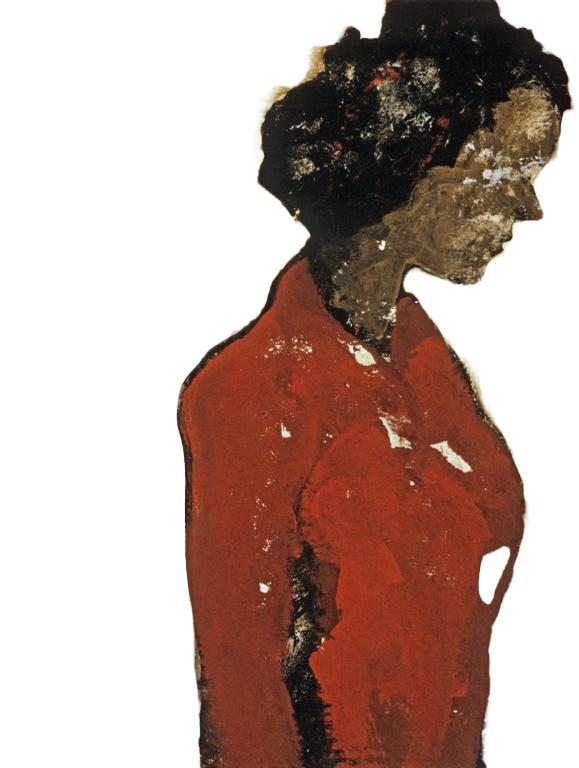
Tullio Vietri, in “La Squilla”, Bologna, 18 dicembre 1958
Tullio Vietri ( intervista a ) novembre 1961
Tullio Vietri, in “Questioni d’arte”, luglio 1969
Tullio Vietri, Nel pessimismo dell’intelligenza e nell’ottimismo della volontà, in “Critica Radicale”, 1989
Tullio Vietri, in “Critica Radicale”, 1990
Esaminate le posizioni teoriche e le opere di Giorgio de Chirico, e pertanto evidenziato il reale significato del suo “realismo dell’enigma”, ovvero del suo “enigmatismo” come qualcuno lo definisce; esaminate le posizioni teoriche e le opere di Carlo Carrà (da quelle di de Chirico nettamente lontane), e pertanto evidenziato il reale significato del suo “realismo magico” o “mitico”, rimangono da esaminare, non già le posizioni teoriche (che risultano mai siano state espresse in forma scritta), ma le opere di Giorgio Morandi. Al fine di evidenziare il reale significato del “mistero morandiano”, come lo definisce Francesco Arcangeli (Giorgio Morandi, Einaudi Torino 1981, p. 87), già pubblicato dalle Edizioni del Milione nel 1964). E pertanto di rispondere alle domande: è Morandi pittore metafisico? è più vicino a Carrà o a de Chirico? Ovviamente dopo aver stabilito se le opere sue seguono i canoni fissati da de Chirico per la sua pittura metafisica o da Carrà per la propria. Indubbiamente quanto scrive Arcangeli (op. cit. pp. 86, 87) facilita l’esame: “Reprimendo quella passione sentimentale che pur non manca di attrarlo”, Morandi porta la sua metafisica del 1918-19 … “al massimo di autorevole e disinteressata purezza, quella dell’antica tradizione mediterranea, di plastica così umanamente deificata, da includere in sè una immobile filosofia di gerarchia morale, di sacrale disciplina, di ordine armonico e non mutevole”.
E tutto ciò si ricava da una attenta lettura che lo stesso Arcangeli compie delle opere di tale periodo, nelle quali “la luce è stregata, un impossibile meriggio senza scampo assedia le cose, ma tutto è dominabile, e dominato dall’occhio e dalla mente (…)”.
Direi che si potrebbe essere d’accordo con le parole di Arcangeli se quel verbo usato al principio del discorso non distorcesse il reale significato, a mio avviso, delle posizioni espresse da Morandi. Reprimere infatti vuol togliere forza con la forza. Quindi togliere forza alla passione sentimentale.
Ragion per cui alla virtù reprimente, alla virtù del superamento della passione, si dovrebbe pertanto la “disinteressata purezza” della sua pittura che è “quella dell’antica tradizione mediterranea”. Non credo infatti si possa parlare di repressione-superamento della passione sentimentale in Morandi, così come non si può parlare di repressione-superamento della passione sentimentale in Picasso … Infatti dice Picasso, l’arte è dramma, frutto di tensione morale, di idee ed emozioni, delle emozioni del pittore “costantemente sveglio davanti ai laceranti, ardenti (…) avvenimenti del mondo”, e che “si modella totalmente a loro immagine”. La pittura non è decorazione, ma “strumento di guerra offensiva e difensiva contro il nemico” (Scritti di Picasso, a cura di Mario De Micheli, Feltrinelli, Milano 1973, pp. 47, 69).
(…) Il parallelo Morandi-Picasso (e ovviamente de Chirico, che le parole di Leymarie chiaramente richiamano) non credo possa sembrare ardito. Anche perché questi autori hanno in comune qualche altra cosa di estremamente importante: la grande lezione di Cezanne. Per Morandi la lezione di Cezanne è indubbiamente fondamentale.
La forte tensione emotiva e formale delle sue opere, fin dal 1911, rimandano costantemente a Cezanne. A tutto Cezanne, e non solo al suo ultimo periodo, il periodo privilegiato dalla critica ufficiale. E pertanto alla pittura di Cezanne che, nel suo insieme valutata, non può non essere definita drammatica.
La pittura di Cezanne, infatti, è espressione sempre di quella forte tensione morale, di quella irruenza lirica, di quella emozione violenta, di quella rivolta contro l’esistente, che sono le caratteristiche della sua personalità, come attesta John Rewald (La Storia dell’Impressionismo, Mondadori, Milano 1976, p. 174). E sono proprio tali caratteristiche che consentono a Cezanne (perché “gli somigliano” direbbe Baudelaire) di amare profondamente Tintoretto e Michelangelo, Ribera e Zurbaran (e direi El Greco, come riconosce Lionello Venturi nel suo famoso studio su Cezanne del 1936), e Daumier e Delacroix.
E tramite la loro lezione di arrivare all’impressionismo con la lezione di Manet … Di Manet che amava … soprattutto quel Velazquez …che proveniva da Ribera e Zurbaran (e da El Greco, quindi) e che era amato da Courbet e Delacroix, da Daumier e Corot, da Degas e Renoir, così come è attestato da Leon Paul Fargue (Velazquez, Editions du Dimanche, Paris 1946, p. 3). Sono proprio tali autori (la loro lezione) che consentono a Cezanne di arrivare, come è attestato dai suoi disegni e dalla sua pittura fino al 1871/72, ad una sorta di espressionismo che fa pensare, in certi momenti a Nolde (vedi per esempio Autopsia, La toeletta funebre …); e poi fra il 1872 e 1878, ad un impressionismo che diventa sempre più sui generis; anzi ad una sorta di “post-impressionismo” caratterizzato sempre più dalla razionalizzazione-geometrizzazione in “cilindri, sfere, coni, il tutto messo in prospettiva”, così come dice Cezanne stesso in una lettera ad Emile Bernard (riportata in Cezanne, Lettere a cura di Duilio Morosini, Bompiani, Milano 1945, p. 107). “Post-impressionismo”, che certamente non è improvvisa, volontaristica, fredda, costruttivistica razionalizzazione-geometrizzazione dell’oggetto naturale nella sua verità oggettiva. Perché non è semplice “superamento” modo di uscire, di oltrepassare, di vincere, quello che da Lionello Venturi (La Via dell’Impressionismo, Einaudi Torino 1970, p. 263) sono chiamate “forzature … espressionistico-romantiche”… “Post-impressionismo”, che caratterizzerà tutta la sua produzione successiva, che è invece sintesi viva, composizione delle varie componenti, che pertanto sono sempre compresenti: il romanticismo della rivolta e contemporaneamente il classicismo della volontà della conoscenza e del tutto dominato e dominabile razionalmente. Del tutto che l’uomo deve dominare razionalmente.
A Cezanne “i cubisti devono quasi tutto. Picasso gli deve molto”, dice così Duilio Morosini nella prefazione al libro citato (p. 13) … A Cezanne anche Morandi deve indubbiamente molto. Alla sua lezione formale perché morale, e morale anche perché formale egli sarà sempre fedele. Non solo negli anni 1911-1914, ma anche nella fase cosiddetta futurista (che futurista non è, semmai cubista) del 1914-1915. E nella fase successiva (1916-inizio 1917) caratterizzata dal recupero di una certa lezione proveniente dalla “secessione” viennese (Klimt), filtrata molto probabilmente, dalla lezione ricevuta da Augusto Majani, suo insegnante all’Accademia di Bologna, giustamente ricordato come grafico, cartellonista e caricaturista di talento (si firmava in tali opere Nasica), fra i rappresentanti più tipici e validi della “scuola bolognese”, “fedele a una linea stilistica ed ideologica che in casi come il suo, qualifica il Liberty movimento di spinta democratica e di impostazione antiaccademica” (Rossana Bossaglia, Il Liberty, Sansoni, Firenze 1974, p. 124, 125). E probabilmente da una certa lezione, ovviamente sempre Liberty (come sembra attestato da Fiori, del 1917, in collezione privata milanese, al n. 31 del Catalogo generale Vol. Primo 1913-1947, Milano 1977 di Lamberto Vitali) ricevuta dal Bistolfi che nel 1907 era stato chiamato dal Comune di Bologna ad erigere il famoso monumento al Carducci all’indomani della morte del poeta.
(…) E alla stessa lezione cezanniana Morandi sarà fedele anche, ovviamente, nella sua fase cosiddetta metafisica (1918-1919) dipingendo il dramma della estrema razionalizzazione-geometrizzazione. In analogia, se si vuole, con quanto faceva Mondrian, espressionista alla Van Gogh e poi alla Munch negli anni fino al 1910-1911 (cioè a circa quaranta anni di età e dopo venti di pittura, come attesta Umbro Apollonio in Mondrian, Milano 1965, p. 4) e poi cubista.
(…) Quella di Morandi pertanto è una razionalizzazione-geometrizzazione di una protesta morale, di un risentimento, di una indignazione, e nello stesso tempo di una speranza nel buon senso borghese, negli ideali della tradizione borghese, nella libertà da essi garantita, perché “il concetto etico supremo è quello di libertà”, come dice Umberto Scarpelli (L’Etica senza Verità, il Mulino, Bologna 1982). Ovviamente senza sortilegio nè evocazione magica, come dice giustamente Cesare Brandi, ricordato da Arcangeli (op. cit. p. 79). Pertanto Morandi nel suo impegno etico è molto vicino a de Chirico, così come si ricava dalle sue opere, e certamente non a Carrà.
E’ vicino cioè a quel de Chirico che proclama la calma, la serenità e la potenza come senso e ragione di essere dell’arte nella sua azione di moralizzazione (Zeusi l’Esploratore, del 1911-15, riportato in Paolo Fossati, Valori Plastici 1918-22, Einaudi, Torino 1981, p. 87), con esclusione di ogni angoscia, stante la certezza della prospettiva. Perché “la potenza dell’intellettuale specializzato, artista e genio, (…) deve porsi come servizio di lotta politica”, dice di de Chirico, “per mutare le condizioni di fatto della situazione” (ibidem). De Chirico stesso, successivamente, su Valori Plastici del 1920, nutrendo ancora la speranza nella propria azione di moralizzazione (attraverso i suoi scritti e le sue opere d’arte), nel condannare l’esaltazione della guerra e le “baldorie futuriste” del dannunzianesimo, scrive “Gli isterismi e le cialtronerie sono condannati nelle urne. Credo che ormai tutti siano sazi di cialtronerie, sia politiche, letterarie o pittoriche” (citato in Massimo Carrà, Metafisica, Mazzotta, Milano 1974, pp. 189, 190). Di fronte ai gravi avvenimenti politici di quegli anni (1919-1922), la violenza organizzata, il fascismo, questa struttura razionale sembra appannarsi, sembra incrinarsi in Morandi così come in de Chirico. Cade la prospettiva dell’effettiva azione nella realtà del loro impegno morale = sociale. Ma sono consapevoli entrambi della verità enunciata da Alberto Savinio nel n. 5 del 1920 di Valori Plastici (riportato in M. Carrà, op. cit. p. 243): “Quando nella mente dell’uomo il ricordo dell’ieri e la speranza del domani si oscurano, egli si affaccia alla soglia del nulla, della disperazione”.
E a tale disperazione essi si oppongono, in un estremo ricorso alla ragione, con esiti diversi, necessariamente. In de Chirico cade il rapporto passato (Grecia, Rinascimento)-presente (mondo industriale)-futuro enigmatico (“albe omeriche”), per dar luogo ad un presente senza passato nè futuro (la sua pittura fino al 1927-28), intervallata dal “romanticismo classicheggiante” delle Ville Romane, narrato nella sua drammaticità di condizionamento cogente dell’individuo senza spazio individuale, senza difesa; e successivamente, ponendosi del tutto al di fuori della metafisica così come da lui teorizzata precedentemente, negli anni 1915-1920, allorquando sente che tale condizionamento (intervenuta la “legge per la difesa dello Stato” nel novembre 1926, lo scioglimento dei partiti, la fine dello Stato liberale) non può non riguardare anche la sua stessa persona, si trasformerà nel passato ironico della favola, della beffa, nella vanagloria di capacità individuali, di qualità rare di pittore e di intellettuale che richiamano inevitabilmente quel secentismo e quel tecnicismo prima disprezzati, perché, diceva, “in arte, se è vera arte, la tecnica non ha nessun ruolo” (Zeusi l’Esploratore, op. cit. p. 86); perché “mostruosa vuotezza” e “favolosa sordità” “campeggiano e troneggiano nella pittura di quel secolo (…)” (La Mania del Seicento in P. Fossati, op. cit., p. 251).
In Morandi invece si avrà una ricerca di salvezza nel ricorso ad una certa descrittività naturalistica (1920-24) nel ricorso ad un certo impressionismo (Renoir, soprattutto), e quindi nell’approdo ad un certo intimismo. Ma è un breve ripensamento di quella lezione, di quella concezione del mondo, per approdare ad un certo ermetismo alla Montale, e non all’ermetismo “ingenuo” alla Ungaretti-Carrà caratterizzato dalla “poetica dell’assenza del tempo”, come dice Giuliano Manacorda (Montale, La Nuova Italia, Firenze 1973, p. 19).
Ad una sintesi di tutte le sue esperienze precedenti, favorita da rinnovati amori per Giotto, Masaccio e Piero. Tutti posti in un certo rapporto con Cezanne, e i “valori tattili”, così come bene indicato da Bernhard Berenson nei suoi famosi quattro libri dedicati alla pittura italiana fra 1894 e 1897.
(…) Tale sintesi compiuta da Morandi negli anni successivi il 1924-25 è la sintesi formale dovuta alla conquistata fede necessaria per vivere e sopravvivere, che sarà “fede nella poesia, intanto”, “il cui oggetto può riuscire oscuro e che consiste”, come dice Montale (Uomini e Idee a cura di Sandro Briosi, riportato in Giuliano Manacorda, op. cit. p. 9) “soprattutto nel vivere con dignità di fronte a se stesso, nella speranza che la vita abbia un senso, che razionalmente ci sfugge, ma che val la pena di sperimentare, di vivere”.
Questo sentimento vivo e profondo è quello stesso sentimento che dalle ragioni storiche contingenti è consentito agli uomini che avrebbero voluto ad essi opporsi, ma che non trovavano, non potevano o non sapevano trovare, per ragioni storiche antiche, tipiche di quel settore pacifistico e quietistico e democratico, anche se non socialista, della piccola borghesia italiana (ma non solo italiana) cui Morandi appartiene, le forze necessarie, i collegamenti necessari all’azione. L’approdo di Morandi è pertanto ad una pittura ancora drammatica, anche se in tono ridotto, rispetto al precedente, nella quale l’eco (non la immediatezza) della felicità di scoperta del sensibile che fu degli impressionisti e di molti post-impressionisti, risuona in lui entro la misura di una vita modesta, paga dell’esistente, in una apparente riduzione al mero rapporto io soggettivo-natura oggettiva. E’ proprio tale riduzione apparente che consente ad Arcangeli di avvicinare Morandi a Wols e a Fautrier, e quindi a Morlotti e a Burri. All’informale (op. cit., passim, in particolare pag. 133). E di sostenere (op. cit., pp. 128, 129) che Morandi “ha aperto, con pochissimi altri che non sono soltanto della pittura, la strada malcerta, sfibrante, angosciata di certi lenti, nascosti europei: Wols, tedesco sottile e profondo, erede di Klee, ma temprato sui vecchi vetri appannati, corrosi, dei bistrots di Parigi; Fautrier, sensualista talvolta aggressivo, più spesso stremato”.
E aggiunge “non è che io sogni di ascendenze che a Morandi potrebbero piacere o non piacere, per il gusto dell’attualità (…) Dirà che mi commuove estremamente la storia patetica di questa pittura, partita dal più alto magistero formale, e passata, grado a grado”, intuita “la vita delle antiche dimore, il germogliare disperato di pochi fiori”, a “questo sobrio, triste, casalingo informel” (ibidem, p. 129) … Ma da Morandi, come è noto, queste ascendenze e discendenze attribuitegli da Arcangeli, stante il loro evidente vuoto morale e intellettuale, il loro mero naturalismo, non furono accettate, approvate, ammesse, perché il formalismo in lui … il dare forma razionale, necessariamente razionale, alle sue emozioni profonde, dipendenti dalla sua concezione etica della vita individuale e sociale conformemente ai principi di eticità e responsabilità, è elemento costitutivo essenziale, elemento strutturale permanente, sempre presente e rintracciabile anche nel momento più “crepuscolare”. La esaltazione dell’informale fatta da Arcangeli non poteva, pertanto, non essere interpretata come condanna (e non già esaltazione come avrebbe voluto Arcangeli) delle componenti formali-ideologiche (sempre inscindibili) tipiche della pittura di Morandi. E Morandi così l’ha interpretata (come risulta da una chiara allusione contenuta in una lettera di Arcangeli, in data 22 aprile 1962 a me inviata ? il suo saggio era in tale data già sottoposto a Morandi ? e da testimonianze verbali di quell’epoca successivamente raccolte). Anche perché tale interpretazione trovava conforto in un’altra incomprensione di fondo della pittura morandiana, pur alla presenza di una esatta lettura testuale.
Arcangeli infatti dice, riferendosi a certe opere del 1929, che “Dalla squisita e profonda e talvolta quasi canoviana descrizione delle apparenze esterne”, “Morandi va tacitamente a picco entro se stesso”; e “senza perdere mai la realtà della figurazione egli preme dall’interno con così desolata forza da creare quasi, nell’effetto”(quindi apparentemente) “una sorta di rovesciamento del processo creativo che gli è proprio. Davvero pare, in un gruppo di opere (…), che Morandi sia partito da un motivo interiore” (op. cit. p. 168).
(…) Che Morandi, la pittura di Morandi, sia espressione della piccola borghesia, lo attesta Francesco Arcangeli (op. cit. p. 35). Io però direi che è espressione di quel settore tradizionale quietistico-pacifistico e democratico, anche se non socialista, della piccola borghesia, che si differenzia, per tali sue caratteristiche da un altro settore della piccola borghesia di formazione ottocentesca, in quell’epoca di declino economico e funzionale-strutturale. Da quel settore rappresentato, in fase ribellistico-eversiva, dagli intellettuali della “generazione del 1896”, della generazione che subisce la sconfitta di Adua e vive la “generale disillusione” che ne discende, unitamente alla angoscia generata dalla organizzazione, che si attua in quegli anni, della classe operaia e dalla sua comparsa sulla ribalta politica nazionale, che furono gli eventi decisivi che diedero il via al nuovo movimento nazionalista, antisocialista e anarcoide di D’Annunzio e Marinetti, di Mussolini e De Ambris, se pur diviso in anti-industrializzatori ed industrializzatori, almeno fino alla seconda guerra mondiale (cfr. Adrian Lyttelton, La conquista del potere, il Fascismo dal 1919 al 1929, Laterza, Bari 1974, passim, in particolare pp. 27, 79).
(…) La lezione di de Chirico e Morandi, pertanto, non può essere dimenticata. Così come non può essere dimenticata quella, bisogna dirlo chiaramente, non troppo da essa distante, anche se deve essere opportunamente purgata, di Sironi, metafisico, e prima, futurista sui generis come Morandi, e poi novecentista sui generis. Perché si deve riconoscere che Sironi è uno dei più grandi artisti del nostro secolo e che tutto ciò che fece “venne dettato dalla buona fede assoluta”, come dice Ettore Camesasca (prefazione a Mario Sironi, Scritti Editi e Inediti, Feltrinelli, Milano 1980, p. VII).
Venne dettato da “responsabilità artistica e umana”, da una fede profonda e da una concezione etica profonda che produssero (nonostante la parzialità e pertanto la falsità a livello scientifico, quindi oggettivamente, della problematica propria della teoria politica professata, anzi direi a causa proprio di tale parzialità sentita, vissuta come necessaria contraddizione insanabile con le esigenze etiche che come tali attengono all’uomo in generale, all’uomo come specie) un’arte fortemente drammatica, tendenzialmente tragica. Pertanto un’arte che “malgrado tutto, si dimostra coinvolta a fondo col suo tempo, nel male e nel bene”, come giustamente dice Ettore Camesasca (ibidem, p. XII), nel rilevare che, necessariamente “fare storia” (e ciò è vero per lo storico, ma anche e soprattutto per l’artista, stando a quanto dice Thomas Mann nelle Lettere a Paul Amann, Milano 1967, pp. 59, 190) “significa anzitutto riconoscere la società e le idee nelle quali un avvenimento si è svolto” e il modo nel quale ogni artista gestisce la fede nei dogmi sociali dominanti. Perché si deve riconoscere che Sironi è in maniera evidente espressione sincera di quel settore della stessa piccola borghesia italiana (e non) e del suo dramma. Di quel settore cioè al quale appartenevano D’Annunzio e Marinetti e poi Carrà e Soffici, Martini e Gentilini e Rosai, quel settore della piccola borghesia che ha creduto di potersi opporre con la violenza e con l’anti-industrialismo alla crisi strutturale-funzionale che colpiva l’individuo borghese. La loro lezione, pertanto e la lezione delle avanguardie storiche cui essi si ispirano e la lezione dei movimenti che tali avanguardie precedono, nonchè la lezione dei grandi maestri dal 1200 al 1800 che essi hanno amato, non possono legittimamente essere dimenticate.
Ovviamente dall’artista-intellettuale, “dal vero artista” che necessariamente “lavora senza preoccuparsi della critica e dei critici” come dice Cezanne (Lettere, op. cit. p. 115). E che pertanto si oppone all’artefice-artigiano, mero manovratore alle dipendenze dell’ideologo-duce di sarfattiana memoria, e di conseguenza del mercato. Non possono essere dimenticate dall’artista-poeta per il quale necessariamente arte-poesia è vita intellettuale e morale indissolubilmente coincidenti, come insegna Eugenio Montale (op. cit. p. 24).
Aligi Sassu, 1960
Gianni Celati, 1960
Stefano Bottari, 1962
Fortunato Bellonzi, 1968
Roberto Costella 2001
Gian Mario Villalta 2010
Roberto Costella, 2018
Eventi & News
Evidenza di momenti particolari, vicini e lontani.
L’ Atelier
L’atelier conserva la ricca collezione pittorica e grafica della famiglia (circa millecinquecento opere tra dipinti e grafica). Periodicamente organizza mostre temporanee al proprio interno in modo da favorire la conoscenza della collezione, esponendo le opere a rotazione.
Si trova a Bologna in via Saragozza 135 sotto lo storico portico di San Luca.
Visitabile su appuntamento da ottobre a giugno, anche con vista guidata.
Il Museo
La Biblioteca Civica, gestita dalla Fondazione Oderzo Cultura, espone il nucleo centrale della collezione di proprietà del Comune di Oderzo, per volontà dell’artista custode delle sue opere (circa quattromila tra dipinti e grafica).
Si trova a Oderzo (TV) in via Garibaldi 80 presso la Biblioteca Civica.
Visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca e su appuntamento.









